Il 23 settembre la nostra aula, fisica e virtuale, ha aperto le sue porte per accogliere una lectio magistralis di Paolo Iabichino, direttore creativo, scrittore pubblicitario e fondatore dell’Osservatorio Civic Brands con Ipsos Italia.
Conosciuto in rete come Iabicus, è per noi di MCI un amico storico e, da sempre, un professionista che ci spinge a riconsiderare i perimetri e i confini entro cui opera chi fa comunicazione, dentro e fuori l’accademia.
Sicuramente nel mondo della pubblicità era già conosciuto, ma con “Invertising”, un libro che ha da poco compiuto dodici anni, è arrivato a chi quel mestiere lo voleva fare.
In quel libro c’era un invito a cambiare il senso di marcia della pubblicità, in un percorso che idealmente oggi trova un nuovo punto di atterraggio in “Scrivere civile. Pubblicità e brand al servizio della società”, libro in uscita per Luiss University Press. Un saggio che inaugura una nuova collana “Armi segrete”, curata proprio da Paolo Iabichino, per rispondere alle problematiche che si presentano quotidianamente a chi si occupa di sostenibilità, impatto, equità e comunicazione.
Ed è a partire dalla domanda ‘dove ci conduce questa nuova strada’ che ha preso il via una conversazione con gli studenti e le studentesse, che ripercorriamo attraverso le parole di Paolo Iabichino.
“Scrivere Civile è un libro che mette insieme un po’ di riflessioni che ho fatto da 3 o 4 anni a questa parte. Sono quindi considerazioni che considerano il contesto fuori, esattamente come “Invertising”, e spero che questo nuovo libro riceva lo stesso tipo di attenzione da parte di chi studia, che è lo stimolo principale che muove il mio scrivere.
Perché scrivevo “Invertising” allora e perché scrivo “Scrivere civile” oggi. Partiamo da qui.
Perché, a un certo punto di un percorso fortunato come il mio, senti l’esigenza di restituire qualcosa a chi, in qualche modo, quella fortuna te l’ha permessa. Da una parte c’è chi studia che, per quanto mi riguarda, è sempre stato un volano molto importante del mio pensiero; il mio scrivere, i miei canali sociali sono seguiti per la maggior parte da ragazzi e ragazze che stanno imparando, molte tesi di laurea sono state fatte su “Invertising” e credo di non aver mai detto di no a una richiesta di intervista per una tesi di laurea, per un approfondimento, per una qualsiasi richiesta che venisse da studenti e studentesse impegnate su queste tematiche.
A un certo punto senti l’esigenza di unire un po’ i puntini di quello che è stato un percorso.
“Invertising” arriva perché nel 2010 sentivo l’esigenza di restituire una sensazione, la sensazione che il digitale avrebbe drammaticamente cambiato il modo di pensare la creatività. Non di veicolarla, perché il mio tema non era Internet come “nuovo media”. Non è che perché vedevo arrivare Youtube o Facebook, spingevo i miei clienti per andare sulle piattaforme. Paradossalmente dicevo proprio il contrario, in tempi non sospetti e non perché ne intravedessi la tossicità, ma perché avevo intuito il rischio che YouTube e Facebook potessero diventare una specie di nuova televisione. Fondamentalmente, mettevo in allarme colleghi, colleghe, manager, chi studiava, che forse era più urgente cambiare il tipo di atteggiamento con cui progettavamo la comunicazione pubblicitaria per queste piattaforme.
Avvertivo che se l’atteggiamento fosse stato lo stesso che mettevamo nella televisione, avremmo rotto anche questo giocattolo. Che poi è esattamente quello che è successo.
Questo, 12 anni fa raccontava “Invertising”.
“Scrivere civile” è un volume che arriva adesso perché mi sono successe, negli ultimi 3 o 4 anni, cose significative, cose importanti e ho sentito l’urgenza di fermarle ancora su alcune pagine di riflessioni. Nel 2018 ero praticamente in una delle posizioni più alte dell’organizzazione in cui lavoravo, direttore creativo esecutivo non solo di Ogilvy ma del gruppo WPP a capo di tutte le agenzie del gruppo in tutta Europa sui 7 brand FCA. È da questa posizione apicale che mi rendo conto realmente di quanto questo mestiere, quello della creatività, fosse stato commoditizzato, fosse solamente l’ultimo anello di una filiera di comunicazione che metteva prima istanze finanziarie, speculando sulle risorse che quella creatività la producevano, in una dialettica cliente-agenzia che non era la relazione che io avevo incontrato negli anni precedenti all’interno di Ogilvy, un’agenzia sana, un’agenzia dove c’era della gentilezza, della civiltà, dialogo tra le persone all’interno e quelle del mondo esterno.
Questo modo di affrontare il mio mestiere, non mi risuonava più. E quindi, lascio nel momento più felice, più fortunato della mia carriera.
Non avevo un piano B, non sapevo cosa avrei fatto il giorno dopo; però, negli anni, avevo seminato, divulgato, mosso da questa volontà formativa. Questa condivisione del sapere, questa voglia di dare, di raccontare le cose belle, oltre a quelle cose brutte, in qualche modo ha ripagato e, ho potuto continuare a scrivere la pubblicità ma da un punto d’osservazione diverso, più attento ai contesti esterni.
Negli ultimi anni, negli ultimi mesi, tutte le cose che mi sono trovato a scrivere avevano questo tipo di tensione all’interno; una tensione creativa che intende dire alle aziende, alle imprese, fondamentalmente a chi guida il mercato: “occupatevi anche del mondo fuori. Cercate di produrre impatto”.
Quanti di voi stanno studiando le tendenze più attuali di questo mestiere, sicuramente si sono affacciati sul tema del purpose.
Sapete cos’è? In inglese vuol dire scopo, quello che un brand dichiara al mondo rispetto al suo stare sul mercato. Risponde alla domanda: sono sul mercato perché?.
Se non l’avete letto andatevelo a leggere, se non l’avete visto andatelo a guardare su YouTube, il TEDx di Simon Sinek “Start with why”, in cui lui spiega meravigliosamente tutto questo, dicendo “ci siamo sempre occupati di dire cosa e di dire come ma ci siamo sempre dimenticati di dire alle persone perché facciamo quello che facciamo”.
E guardate che quando interrogate le aziende sul perché fanno quello che fanno, difficilmente vi sentirete dire “per arricchirci” ma, questo, è quello che è diventato questo mestiere, il mestiere di chi per anni ha inseguito l’etica del profitto a tutti i costi.
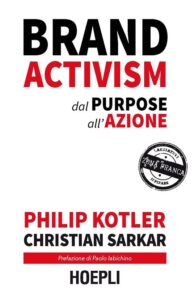 Se studiate un manuale di economia, troverete scritto che marketing è creare valore per gli stakeholders, ma i più attenti di voi, i più aggiornati di voi che hanno letto “Brand Activism. Dal purpose all’azione”, l’ultimo manuale del prof. Kotler che questa disciplina se l’è inventata negli anni ’60, si sono trovati davanti una riflessione, avviata oltre una decina di anni fa con “Marketing 3.0”, in cui alle 4 P del marketing se ne aggiunge una quinta: People. E adesso la sesta, Planet.
Se studiate un manuale di economia, troverete scritto che marketing è creare valore per gli stakeholders, ma i più attenti di voi, i più aggiornati di voi che hanno letto “Brand Activism. Dal purpose all’azione”, l’ultimo manuale del prof. Kotler che questa disciplina se l’è inventata negli anni ’60, si sono trovati davanti una riflessione, avviata oltre una decina di anni fa con “Marketing 3.0”, in cui alle 4 P del marketing se ne aggiunge una quinta: People. E adesso la sesta, Planet.
“Brand Activism” è la conclusione ideale di questo percorso che lascia intravedere una specie di epifania di questa disciplina.
Kotler ci ha consegnato un’opera importante, che nasce negli USA, un testo che dice che le aziende devono prendere posizione politicamente, che individua delle tensioni culturali all’interno delle quali le aziende devono muoversi, indica modelli, canvas funnel, usa dei riferimenti politici e ideologici molto importanti ma come pretesti narrativi. Io di quel volume ho avuto il privilegio e l’onore di firmare la prefazione dell’edizione italiana perché mi sembrava importante sottolineare, anche in Italia, come il prendere posizione stesse diventando fondamentale.
Ma Kotler non ne fa un discorso di economia civile.
Parla di Patagonia, di Nike e dice che adesso è il momento che il marketing si occupi del bene comune, della collettività, della comunità non perché ci siano gli obiettivi SDG, ma perché queste tensioni, in questo momento, sono sentite, sono avvertite, dai pubblici che comprano i prodotti.
—
Se vi dico economia civile cosa vi viene in mente? Vi risuona?
“Economia civile” è il libro di un professore che si chiama Stefano Zamagni ma le sue origini, e questa cosa è strabiliante, risalgono al 1753 quando nasce la prima cattedra di Economia al mondo, qui, in Italia all’Università di Napoli.
Il professore a cui viene affidato questo corso di laurea, Antonio Genovesi, lo chiama Economia Civile e nel 1760-62 dà alle stampe il manuale di Economia Civile e, già qui, viene sottolineato che non puoi fare profitto solo per fare profitto, non puoi creare valore solo e soltanto per gli azionisti e per gli imprenditori; fai impresa, fai mercato, fai economia e lo fai in maniera civile se ti occupi anche della comunità, del territorio.
Chi vi ricorda?
Uno per tutti, l’imprenditore più citato su queste tematiche: Olivetti.
Olivetti ha costruito la sua impresa su questa impostazione e così hanno fatto i Crespi, i Ferrero e altre grandi imprese del nostro paese. Sono loro che, per la prima volta, hanno affiancato alle proprie fabbriche ospedali, scuole per i bambini.
Non è proprio il modello di Facebook, quello dalla mitologia delle start up che aggiungono sale giochi alle proprie sedi aziendali per far rimanere ancora più a lungo i dipendenti.
Sono due atteggiamenti completamente diversi: da una parte, quello del profitto che si occupa del bene civile e, dall’altra, quello del profitto fine a se stesso.
Ed è quest’ultimo che viene finalmente sconfessato dalle nuove generazioni che sembra si muovano scegliendo le marche in funzione di quello che le marche rappresentano.
Scelgono, e non comprano. Saranno queste le nuove corde di consumo e non è una tendenza, ma un fenomeno destinato a restare.
Per anni, abbiamo depredato risorse. Abbiamo costruito aziende su un’economia di tipo estrattiva.
Dobbiamo invertire questa direzione e iniziare a parlare di economia generativa, che implica non tanto l’essere circolare ma interrogarsi, prima di costruire qualsiasi oggetto destinato al consumo, sull’impatto che vogliamo avere sull’ambiente e sulla vita delle persone.
Questo per me significa fare mercato. Vuol dire intercettare una tensione culturale e non costruire un consumer insight a tavolino; capire che tipo di azione, che tipo di prodotto o di servizio mettere in campo per dare alle persone ciò che quella tensione culturale sta reclamando.
La logica del profitto guida sempre il nostro mestiere, certo che dobbiamo vendere qualcosa a qualcuno, ma si può fare profitto occupandosi di tematiche che creano valore sì per chi guida l’impresa, sì per gli azionisti, ma anche per il pubblico a cui ci rivolgiamo, per la società in cui siamo immersi, per la nostra comunità interna e i dipendenti.
Questa è l’economia civile.
E per chi ha fatto della creatività la propria professione, c’è una specie di chiamata per questo tipo di narrative. E ci riesce particolarmente bene quando interveniamo, non tanto alla fine del percorso, ma all’inizio.
—
Quanta consapevolezza c’è nella classe imprenditoriale di questa tensione, di questa urgenza di cambiare il modo di fare impresa?
Questa sensibilità c’è.
L’ultima parte del libro è dedicata alle interviste condotte in seno all’Osservatorio Civic Brands perché fa toccare con mano che non sono soltanto Altromercato o Parmigiano Reggiano ad avere questa consapevolezza ma anche la grande multinazionale, la piccola impresa o la start up.
Qual è la cattiva notizia, quindi? Che in un momento di crisi, di recessione, queste tematiche sono più difficili da portare all’attenzione di chi investe perché non danno risultati nel breve periodo. Per questo è importante la progettazione, guardare verso un orizzonte più lontano del domani.
Chi fa mercato questa lezione la conosce perfettamente; chi ha investito su questi principi, in tempi non sospetti, oggi sta raccogliendo. Chi ha costruito il suo modello di business sul fast and furious qualche problemino inizia invece ad averlo.
Sono tutte tematiche che, in Italia, abbiamo sempre avuto in pancia ma è un peccato che le abbiamo delegate a terzi e, oggi, arrivano dall’estero a dirci “Start with why” quando c’era Genovesi che aveva costruito una cattedra sui temi dell’economia generativa. Nel 1750.
Ed è su questi concetti si è fatta molta parte della storia della nostra imprenditoria.”



